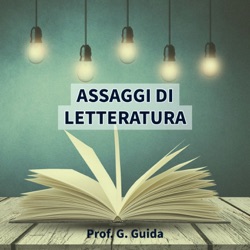Avsnitt
-
ep. 88 st. 1
Guido Guinizzelli supera la lirica siciliana e la siculo-toscana, proponendo una novità inedita: la fedeltà incondizionata all'ispirazione d'Amore...
Per capire meglio questo discorso, vi incito a recuperare le puntate precedenti alla prosa novellistica, dalla 60 alla 75. Ripartiamo da qui e riprendiamo il discorso sulla poesia del Duecento. -
ep. 87 st. 1
Il "Novellino" è una raccolta che dà inizio alla novellistica italiana.
"... si vogliono insegnare i fiori del parlare e i comportamenti nobili"; lo si vuol fare prendendo esempio da chi è colto e nobile per nascita, ma lo si fa per tramandare questo sapere ai poveri di cultura, ai "minori", perché a loro volta possano raccontare ed insegnare a 2colore che non sanno e che desiderano sapere". -
Saknas det avsnitt?
-
ep. 86 st. 1
Con il tempo, le cose sono cambiate l'attenzione dell'uditorio si è spostata sempre di più sulla narratio, cioè sulla bellezza della storia e sul modo in cui veniva raccontata. L'insegnamento morale è diventato piano piano meno importante, e così l'exemplum si è trasformato in una nuova forma di racconto: la novella. -
ep. 85 st. 1
Le narrazioni della tradizione orientale in lingua araba sono modelli vicini ai nostri exempla e fabliaux, ma presentano delle novità che l'Occidente farà proprie e riutilizzerà. Questi testi (come "Il libro dei sette savi", "Il romanzo di Balaam e Josaphat" e "Le mille e una notte") sono stati molto influenti a partire dal Duecento in Europa, grazie a traduzioni, adattamenti e rielaborazioni da parte di intermediari. -
ep. 84 st. 1
J. Le Goff, in "Tempo della Chiesa e tempo del mercante" spiega come l'Oriente fosse concepito dall'uomo medievale come un mondo onirico nel quale lasciarsi andare ed essere senza inibizioni.
Si propone anche un commento all'importante considerazione sull'Oriente che è stata elaborata dallo studioso di origine palestinese Edward Walter Said. -
ep. 83 st. 1
Marco Polo scrive di meraviglie, ma non scrive per meravigliare; rimane sempre con uno sguardo analitico, quasi da moderno reporter. Sicuramente si è posto nei confronti di quel mondo nuovo con un atteggiamento molto aperto e tollerante. Un atteggiamento lodevole per un uomo occidentale della sua epoca. Se pensiamo agli atteggiamenti dei conquistadores di circa duecento anni dopo in America, Marco Polo si proietta già nel futuro, ben oltre gli albori dell'Età Moderna. -
ep. 82 st. 1
Il "Milione" di Marco Polo è un'opera rivoluzionaria perché non ha avuto soltanto delle ricadute di carattere culturale e narratologico, ma anche di natura etnologica, pratica, nautica, geografica, ecc... E' un capolavoro anche perché è un'opera sui generis... è una crocana, ma anche un trattato geografico; è un romanzo di avvantura, ma anche un manuale per viaggiatori e mercanti; contiene saggi diplomatici e di carattere religioso; è un repertorio di leggende e altro ancora! -
ep. 81 st. 1
Dino Compagni è una figura di spicco nel panorama letterario e storico italiano del Duecento, e la sua opera, la "Cronica delle cose occorrenti ai tempi suoi", riveste un'importanza cruciale per comprendere lo sviluppo della prosa volgare in quel periodo.
La "Cronica" di Dino Compagni, pur essendo un'opera di parte, che presenta molti caratteri di soggettività, e non sempre storicamente accurata, rimane una testimonianza fondamentale per comprendere il clima politico e culturale della Firenze comunale del Duecento e per apprezzare le nascenti potenzialità della prosa volgare italiana. È un tassello cruciale nella transizione dal latino al volgare come lingua letteraria e culturale in Italia. -
ep. 80 st. 1
Vale la pena approfondire la realtà documentaria della poesia comica. Franco Suitner ci dice chiaramente che la poesia comica ha avuto un ruolo fondamentale nella documentazione degli aspetti concreti della vita comunale del Duecento nella nostra penisola. Questo tipo di poesia si può considerare una prima affermazione di realismo letterario.
Passi scelti tratti da "Poesia satirica e giocosa nell'età dei Comuni", Antenore editore, Padova 1983. -
ep. 79 st. 1
Siamo sicuri che Cecco Angiolieri voglia davvero dissacrare la vita per un risentimento esistenziale? Il suo riso/sorriso deve per forza indurci a pensare in termini leopardiani (o semplicemente umoristici)? Il suo non potrebbe essere, come ha suggerito Luigi Pirandello, soltanto un gioco?
Lettura di un passo scelto, tratto dal saggio "Cecco Angiolieri" di Mario Marti, contenuto in "Dizionario biografico degli italiani", vol III, istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1961. -
ep. 78 st. 1
Oltre al commento al sonetto "S'i' fosse foco arderei il mondo" di Cecco Angiolieri, si propone la riflessione del 1908 di Luigi Pirandello, il quale ha negato che Cecco Angiolieri avesse la volontà di comunicare nelle sue opere, oltre al riso e alla dissacrazione, anche dolore e amarezza per la condizione umana. -
ep. 77 st. 1
Non cadiamo nell'errore di pensare che Cecco Angiolieri non fosse colto e non conoscesse il buongusto. Egli ha fatto una scelta: si nega ad un impegno politico (diversamente da Guittone d'Arezzo ad esempio) e non si vuole nemmeno impegnare sul piano morale (né amoroso, né religioso). E' un radicale, un estremista; ma c'è chi ha osservato che possa essere in realtà un malinconico e un disperato, atterrito e combattuto da un desiderio di elevazione impraticabile.
Tre cose solamente mi so ’n grado,
le quali posso non ben men fornire:
ciò è la donna, la taverna e ’l dado;
queste mi fanno ’l cuor lieto sentire.
Ma sì me le conven usar di rado,
ché la mie borsa mi mett’al mentire;
e quando mi sovvien, tutto mi sbrado,
ch’i’ perdo per moneta ’l mie disire.
E dico: – Dato li sia d’una lancia! –
Ciò a mi’ padre, che mi tien sì magro,
che tornare’ senza logro di Francia.
Trarl’un denai’ di man serìa più agro,
la man di pasqua che si dà la mancia,
che far pigliar la gru ad un bozzagro. -
Ep. 76 st. 1
La poesia didattica del Duecento è un fenomeno letterario ricco e variegato, che testimonia la vitalità del volgare italiano e la volontà di utilizzare la poesia per scopi educativi e morali. Sebbene spesso meno apprezzata rispetto alla lirica amorosa o alla narrazione cavalleresca, rappresenta un tassello fondamentale per comprendere la nascita e lo sviluppo della letteratura italiana (Brunetto Latini, Uguccione da Lodi, Anonimo Genovese, ecc).
La poesia popolare e giullaresca del Duecento è un fenomeno fondamentale per comprendere la cultura e la letteratura italiana delle origini. Testimonia la vitalità del volgare, la ricchezza della cultura popolare e il ruolo centrale dei giullari come artisti, informatori e animatori della vita sociale e culturale dell'epoca (Rustico Filippi e Cecco Angiolieri). -
ep. 75 st. 1
Apriamo una piccola parentesi per dare spazio al gruppo delle trovatrici occitaniche delle quali non è stato approfondito prima l'argomento. In mezzo a tante voci maschili, esiste un corpus prodotto da donne; è un numero esiguo di nomi, ma comunque significativo.
Comtessa de Dia: la più famosa tra le trobairitz, vissuta nel XII secolo. Le sue poesie parlano d’amore con grande passione e sicurezza. Il suo componimento più noto è "A chantar m’er de so qu’eu no volria", unico testo di una trobairitz giunto fino a noi con melodia.
Azalais de Porcairagues: poetessa attiva tra il 1150 e il 1200, nota per la sua poesia dedicata a un cavaliere crociato.
Castelloza: probabilmente vissuta nel XIII secolo, è autrice di poesie d’amore in cui esprime il dolore per un amante infedele.
Béatrice de Die: a volte confusa con la Comtessa de Dia, ma comunque una delle poetesse più note dell’epoca. -
ep. 74 st. 1
Il ruolo di iniziatore delle pratiche poetiche dei siculo-toscani spetta a Bonagiunta Orbicciani; poi possiamo trovare tanti altri nomi di poeti a noi pervenuti che si sono distinti, ognuno a proprio modo, chi più chi meno, nella Toscana dell'epoca.
Chiaro Davanzati, Andrea Monte, Inghilfredi, Mino Mocato, Folcacchiero dei Folcacchieri, Meo Abbracciavacca, Panuccio dal Bagno, Tiberto Galinziani, Galletto, Pucciandone Martelli, ecc... La puntata si chiude con un degno commento alla prima poetessa in lingua volgare italiana: Compiuta Donzella. -
ep. 73 st. 1
Questo componimento è un chiaro esempio dell'impegno morale e civile di Guittore, il quale incarne un nuovo tipo di intellettuale, un intellettuale comunale, cittadino. Già qui si nota la differenza con la poesia provenzale e siciliana.
Siamo di fronte al primo esempio di poesia civile della nostra letteratura!
Ahi lasso, or è stagion de doler tanto
a ciascun om che ben ama Ragione,
ch’eo meraviglio u’ trova guerigione,
ca morto no l’ha già corrotto e pianto,
vedendo l’alta Fior sempre granata
e l’onorato antico uso romano
ch’a certo pèr, crudel forte villano,
s’avaccio ella no è ricoverata:
ché l’onorata sua ricca grandezza
e ’l pregio quasi è già tutto perito
e lo valor e ’l poder si desvia.
Oh lasso, or quale dia
fu mai tanto crudel dannaggio audito?
Deo, com’hailo sofrito,
deritto pèra e torto entri ’n altezza?
Altezza tanta êlla sfiorata Fiore
fo, mentre ver’ se stessa era leale,
che ritenea modo imperïale,
acquistando per suo alto valore
provinci’ e terre, press’o lunge, mante;
e sembrava che far volesse impero
sì como Roma già fece, e leggero
li era, c’alcun no i potea star avante.
E ciò li stava ben certo a ragione,
ché non se ne penava per pro tanto,
como per ritener giustizi’ e poso;
e poi folli amoroso
de fare ciò, si trasse avante tanto,
ch’al mondo no ha canto
u’ non sonasse il pregio del Leone.
Leone, lasso, or no è, ch’eo li veo
tratto l’onghie e li denti e lo valore,
e ’l gran lignaggio suo mort’a dolore,
ed en crudel pregio[n] mis’ a gran reo.
E ciò li ha fatto chi? Quelli che sono
de la schiatta gentil sua stratti e nati,
che fun per lui cresciuti e avanzati
sovra tutti altri, e collocati a bono;
e per la grande altezza ove li mise
ennantir sì, che ’l piagãr quasi a morte;
ma Deo di guerigion feceli dono,
ed el fe’ lor perdono;
e anche el refedier poi, ma fu forte
e perdonò lor morte:
or hanno lui e soie membre conquise.
Conquis’è l’alto Comun fiorentino,
e col senese in tal modo ha cangiato,
che tutta l’onta e ’l danno che dato
li ha sempre, como sa ciascun latino,
li rende, e i tolle il pro e l’onor tutto:
ché Montalcino av’abattuto a forza,
Montepulciano miso en sua forza,
e de Maremma ha la cervia e ’l frutto;
Sangimignan, Pog[g]iboniz’ e Colle
e Volterra e ’l paiese a suo tene;
e la campana, le ’nsegne e li arnesi
e li onor tutti presi
ave con ciò che seco avea di bene.
E tutto ciò li avene
per quella schiatta che più ch’altra è folle.
Foll’è chi fugge il suo prode e cher danno,
e l’onor suo fa che vergogna i torna,
e di bona libertà, ove soggiorna
a gran piacer, s’aduce a suo gran danno
sotto signoria fella e malvagia,
e suo signor fa suo grand’ enemico.
A voi che siete ora in Fiorenza dico,
che ciò ch’è divenuto, par, v’adagia;
e poi che li Alamanni in casa avete,
servite i bene, e faitevo mostrare
le spade lor, con che v’han fesso i visi,
padri e figliuoli aucisi;
e piacemi che lor dobiate dare,
perch’ebber en ciò fare
fatica assai, de vostre gran monete.
Monete mante e gran gioi’ presentate
ai Conti e a li Uberti e alli altri tutti
ch’a tanto grande onor v’hano condutti,
che miso v’hano Sena in podestate;
Pistoia e Colle e Volterra fanno ora
guardar vostre castella a loro spese;
e ’l Conte Rosso ha Maremma e ’l paiese,
Montalcin sta sigur senza le mura;
de Ripafratta temor ha ’l pisano,
e ’l perogin che ’l lago no i tolliate,
e Roma vol con voi far compagnia.
Onor e segnoria
adunque par e che ben tutto abbiate:
ciò che desïavate
potete far, cioè re del toscano.
Baron lombardi e romani e pugliesi
e toschi e romagnuoli e marchigiani,
Fiorenza, fior che sempre rinovella,
a sua corte v’apella,
che fare vol de sé rei dei Toscani,
dapoi che li Alamani
ave conquisi per forza e i Senesi. -
ep. 72 st. 1
Guittone d'Arezzo va oltre la concezione della poesia come puro fatto lirico e la intende più concretamente e attivamente come uno strumento per l'argomentazione logica.
Lettura da un estratto dell'opera "Lirici del Duecento" di Carlo Salinari, UTET, Torino 1951. -
ep. 71 st. 1
Guittone d'Arezzo è il più importante autore del gruppo dei siculo-toscani; tanto da avere per molto tempo a seguire numerosi imitatori del suo stile, i cosiddetti "guittoniani".
La canzone politica e la forma-libro del proprio canzoniere sono il lascito più importante di questo autore per noi ormai dimenticato, a causa del suo estremo rigore formale e manieristico. Dobbiamo però risconoscergli un seme fondamentale per il germoglio di un'espressione lirica nuova e moderna. -
ep. 70 st. 1
Siamo sicuri che la poesia della Scuola Siciliana avesse trovato una vasta eco in Toscana e in Emilia-Romagna. Numerose sono infatti le testimonianze che attestano rapporti frequenti tra i funzionari della Magna Curia con i Comuni dell'Italia centrale e centro-settentrionale.
Dopo la caduta degli Svevi, ci fu una totale esportazione, per quanto possibile, della produzione letteraria e culturale siciliana, la quale venne recuperata, ripresa e poi trasformata per dare vita alla nuova tradizione ribattezzata "siculo-toscana. -
ep. 69 st. 1
Viene proposta in questa puntata una riflessione sul valroe della Scuola Siciliana. Si fa riferimento a due brani interessanti:
La posizione di Dante Alighieri sulla Scuola Siciliana, tratta dal "De Vulgari Eloquentiae";Alcuni passi scelti tratti dal saggio di R. Antonelli dal titolo "Introduzione a Giacomo da Lentini", contenutoin "I poeti della Scuola Siciliana", vol I, Mondadori, I Meridiani, Milano 2008. - Visa fler